CINEMA A RISCHIO ZERO
Amazon Prime. VOTO 4,5
L’ultima fatica di Alan Ball si avvale di un cast in stato di grazia, ma scivola sui più triti luoghi comuni per raccontare i conflitti interiori di un omosessuale ripudiato dal padre.
Se un nome importante dell’entertainment americano come Alan Ball scende in campo venti anni dopo aver firmato la sceneggiatura dell’epocale (a suo modo…) “American Beauty” e si piazza persino dietro la macchina da presa per il secondo lungometraggio da regista (“Niente velo per Jasira” è addirittura del 2008), allora è lecito attendersi una sorta di film ‘bussola’: una di quelle opere che si valutano per capire da che parte stia andando un certo cinema americano mainstream.
Senza pretese di completezza, si capisce, ma sicuramente con la giusta dose di curiosità nei confronti di un autore non prolifico e quindi, implicitamente, selettivo nelle sue scelte. Insomma, se Alan Ball dopo una lunga parentesi dedicata alle serie tv (“Six Feet Under”, “True Blood” e “Banshee – La città del male”), mette in moto una macchina produttiva, ci si aspetta che tracci una direzione e tiri fuori dal taschino un distintivo narrativo ed estetico.
“Uncle Frank”, da lui anche prodotto, racconta la storia di un professore omosessuale (lo zio Frank del titolo, interpretato da Paul Bettany) vista con gli occhi della nipote diciottenne (la sempre più sorprendente Sophia Lillis). Un professore che non ha mai fatto ufficialmente ‘coming out’ con la famiglia conservatrice e si è rifugiato nei vicoli più evoluti e bohemien della New York dei primi anni ‘70 (ma il film ignora qualsiasi accenno storico, visto il tema trattato, ai moti di Stonewall), lontano dall’ambiente retrogrado della rurale Creekville, nel South Carolina, dove è stato partorito, cresciuto e infine ripudiato.
E dove è nata e cresciuta, anche sua nipote Beth, per la quale Frank rappresenta il saggio uomo di mondo, prodigo di consigli per lei, così intraprendente e sognatrice, imprigionata in una hometown sonnolenta e ottusa.

Questa la sintesi del primo atto di una tragicommedia che poi scivola nel road movie (un lutto costringe infatti Frank e Beth – nel frattempo trasferitasi a New York per studiare nell’università dello zio – a tornare a Creekville per il funerale) e si conclude con il melodramma familiare in cui nodi e retroscena vengono al pettine, seguendo però i facili rovesci narrativi e un processo catartico approssimativo che uno si aspetterebbe da una soap opera o da un tv movie targato Hallmark.
L’idea interessante del film di Alan Ball si trova tutta nel suo essere, di fatto, una duplice storia di formazione. Il percorso del professore gay che, in concomitanza del lutto familiare, trova finalmente il coraggio di uscire dal guscio in cui si è rintanato per decenni, si accosta al tragitto di Beth, giovane donna che si emancipa fuori dalla provincia e conosce finalmente sia le tante sfumature del mondo, sia i segreti scottanti della famiglia e le vulnerabilità di un mentore da sempre idolatrato.
L’idea non originale, ma intrigante, sprofonda nel burrone di uno svolgimento generico e deludente, che impila soluzioni stereotipate, imponendo nel suo incedere narrativo un implicito giudizio morale, una divisione netta fra buoni e cattivi, fra giusto e sbagliato, senza tracce di ambiguità. Alla ricerca dei facili applausi di una claque che speriamo non sia disposta ad attribuirglieli.
Alan Ball butta giù uno script elementare e lo dirige avvalendosi di accomodamenti banali come l’utilizzo del flashback per ripercorrere il tragico e irrisolto trauma adolescenziale del protagonista.
Si affida, inoltre, al comodissimo impiego della voce fuoricampo (di Beth) per ammiccare allo spettatore affidando alla ragazza la parte della testimone ingenua ma complice. E poi alimenta i fuochi d’artificio del luogo comune correlando la crisi del protagonista a una sua ricaduta nel tunnel dell’alcolismo (un classico…), senza nemmeno risparmiarsi la descrizione del fidanzato di Frank, Wally, quale sensibile baluardo d’acciaio degli omosessuali di tutto il mondo conosciuto e dintorni (il tizio viene dall’Arabia Saudita ed è musulmano): Wally è il saggio ed esotico (con le piccole stravaganze di prammatica) equilibratore del rapporto di coppia, in contrasto con l’intellettuale tutto d’un pezzo che si rivela fragile nel momento topico, quando il destino lo obbliga a fare i conti con la sliding door della sua giovinezza.
 Per non farci mancare nulla, in questo banchetto di bigiotteria cinematografica, troviamo anche la figura del patriarca retrivo, bifolco e timorato di Dio, la cui dipartita diventa una sorta di ‘tana libera tutti’ per una famiglia i cui componenti si rivelano, come d’incanto, degli illuminati e pacati progressisti di larghe vedute. Le donne in primis, naturalmente, con l’esclusione di una nonna totalmente rincoglionita che simboleggia banalmente il pensiero reazionario diventato istantaneamente innocuo e macchiettistico, dopo che il destino ha compiuto quel parricidio che forse Frank covava nel suo rimosso. Ma questo desiderio inconscio sarebbe stato lo spunto per spingere il film altrove, in un territorio più impervio e meno consolatorio.
Per non farci mancare nulla, in questo banchetto di bigiotteria cinematografica, troviamo anche la figura del patriarca retrivo, bifolco e timorato di Dio, la cui dipartita diventa una sorta di ‘tana libera tutti’ per una famiglia i cui componenti si rivelano, come d’incanto, degli illuminati e pacati progressisti di larghe vedute. Le donne in primis, naturalmente, con l’esclusione di una nonna totalmente rincoglionita che simboleggia banalmente il pensiero reazionario diventato istantaneamente innocuo e macchiettistico, dopo che il destino ha compiuto quel parricidio che forse Frank covava nel suo rimosso. Ma questo desiderio inconscio sarebbe stato lo spunto per spingere il film altrove, in un territorio più impervio e meno consolatorio.
Un’opera, quella di Alan Ball, che vorrebbe forse intercettare i pericoli relativi a ogni tipo di emarginazione che sono ancora insiti nel presente. Un altro messaggio di facile presa, su cui non è possibile non essere d’accordo, ma che viene recapitato scegliendo come base di lancio gli anni ‘70.
Considerando il resto delle scelte pigre operate da Ball all’interno del testo filmico, non è da escludere che gli anni ’70 rappresentino per lui una sorta di oasi modaiola, un ‘decennio-luogo’ trattato ormai alla stregua di un bioparco in cui ospitare tutto il dicibile e il mostrabile senza infastidire nessuno. Quasi un genere a se stante in cui recintare un cinema a rischio zero.
..:::..
L’ALGORITMO UMANO CONSIGLIA
 American Beauty (Netflix/Tim Vision)
American Beauty (Netflix/Tim Vision)
Cinque premi Oscar, tre Golden Globe, l’esordio alla regia di Sam Mendes e uno scalpore generato in lungo in largo nel mondo di fine anni ’90. Questo il bottino del film sceneggiato da Alan Ball e interpretato da Kevin Spacey e Annette Bening. Si parla di un quarantenne in crisi, stufo della moglie, del lavoro e di una vita imprigionata in uno schema. Punto e basta: Lester Burnham, questo il suo nome, si infatua della lolitesca vicina di casa (Mena Suvari), comincia a lavorare in un fast food e prende di petto la crisi di mezza età. Ma non ha fatto i conti con molte cose. Una pellicola che all’epoca fu salutata come scorretta e ribelle ma a dissezionarla per bene non è altro che un’operazione furba e reazionaria. Confezionata alla grande, ma sovversiva solamente in superficie.
 Weekend (Amazon)
Weekend (Amazon)
L’esordio alla regia dei britannico Andrew High racconta il fine settimana di passione fra Russell e Glen, che si incontrano in un gay club di venerdì e trasformano una notte di sesso in un weekend in cui ridefiniscono se stessi. Un melodramma contenuto ma esplosivo, una storia in sordina per un cinema di dialoghi in cui i due protagonisti si scoprono gradualmente, di rivelazione in rivelazione, entrambi ignari del background dell’altro. La macchina da presa è piazzata nel presente e anche noi spettatori sfogliamo una a una le pagine di due anime complesse, orientandoci fra brusii, gesti e palpiti in un’opera di impressionate schiettezza.
 La terra di Dio (Rakuten)
La terra di Dio (Rakuten)
Love story nella campagna dello Yorkshire. La dirige Francis Lee, premiato per la miglior regia al Sundance Festival. La solitudine che attanaglia il giovane fattore Johnny Saxby ha solo due sfoghi: l’alcol e il sesso occasionale. Fino all’arrivo dell’affascinante ragazzo rumeno Gheorghe che si stabilisce come lavoratore stagionale nella stessa fattoria e si stabilisce soprattutto nel cuore Johnny, assetato di emozioni a lui ancora sconosciute. La desolazione fa spazio alla gioia e alla trepidazione. Un duplice cammino alla scoperta di se stessi; una lussureggiante educazione sentimentale interiore ambientata nella brulla e ostile realtà contadina.

 American Beauty (Netflix/Tim Vision)
American Beauty (Netflix/Tim Vision)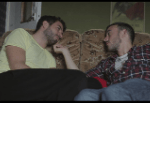 Weekend (Amazon)
Weekend (Amazon)